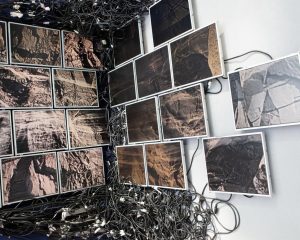Italia indietro su mobilità sostenibile e settore automotive: secondo Legambiente,
pesano i tagli ai fondi dirottati sul Ponte sullo Stretto e i ritardi infrastrutturali
Al Fondo automotive destinati appena 450 milioni
In Italia la mobilità sostenibile procede a rilento, ostacolata soprattutto dal taglio delle risorse. La Legge di Bilancio 2024 non prevede fondi per il trasporto rapido di massa, la ciclabilità e la mobilità dolce, mentre l’87% degli investimenti infrastrutturali è destinato al Ponte sullo Stretto fino al 2038. Anche il Fondo Automotive subisce una drastica riduzione: dagli 8,7 miliardi inizialmente previsti entro il 2030, si scende a 450 milioni nel 2025 e a soli 200 milioni annui per gli anni successivi.
L’Italia continua inoltre a detenere il primato per il più alto tasso di motorizzazione dell’UE, con 694 auto ogni 1.000 abitanti (contro la media UE di 571), e città dove l’emergenza smog è cronica. Le infrastrutture per il trasporto pubblico rimangono insufficienti rispetto alle capitali europee. Tuttavia, si registra un incremento dei punti di ricarica per veicoli elettrici: il Paese conta oggi 64.391 colonnine, più di Regno Unito, Francia e Germania. Diverse città, come Milano, Roma e Messina, si distinguono per iniziative a favore di una mobilità più sicura e sostenibile.
Questa è la fotografia scattata da Legambiente con il primo Forum Nazionale Mobilità, organizzato a Roma in collaborazione con Enel, per fare il punto sulle prospettive della mobilità sostenibile e dell’industria automotive. Quest’ultima, un tempo fiore all’occhiello dell’economia italiana, oggi è in difficoltà, stretta tra la necessità di una transizione ecologica e l’assenza di una strategia industriale adeguata.
Legambiente chiede al governo Meloni un’inversione di rotta immediata, con il ripristino del Fondo Automotive, maggiori risorse per il trasporto pubblico locale, un piano di elettrificazione, il rilancio delle gigafactory nazionali e un utilizzo mirato del Social Climate Fund.
Mobilità sostenibile, le criticità della mobilità urbana
Dalla campagna Città2030 – Come cambia la mobilità, emerge quanto ancora ci sia da fare. Nessuna delle 17 città analizzate – tra cui Milano, Bologna, Roma, Napoli e Firenze – rispetta i limiti della direttiva europea sulla qualità dell’aria previsti per il 2030. Per rientrare nei parametri, nei prossimi cinque anni dovranno ridurre le concentrazioni di PM10 dal 3% al 35% e di NO2 dal 5% al 40%.
Il tasso di motorizzazione rimane alto, con picchi di 78 auto ogni 100 abitanti a Olbia, 66 a Roma e 61 a Napoli, ben superiori alle grandi città europee come Parigi (25), Amsterdam (26) e Londra (36). Questo si traduce in una mobilità ancora dominata dall’auto privata, con percentuali che superano il 50% in molte città, arrivando fino all’81% a Olbia. In confronto, a Parigi solo il 4,3% dei cittadini usa l’auto per gli spostamenti quotidiani.
Anche la sicurezza stradale è un problema: la maggior parte degli incidenti avviene su strade urbane, con un rapporto morti/feriti che raggiunge picchi di 8,4 ogni 1.000 abitanti a Firenze e Genova, 7,3 a Milano e 6,1 a Roma. Se il trend di riduzione non accelera, nessuna città riuscirà a dimezzare i decessi stradali entro il 2030, come previsto dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale.
Segnali di cambiamento e buone pratiche
Non mancano, però, esempi virtuosi. Ben 16 delle 17 città analizzate hanno avviato il rinnovo delle flotte di autobus con mezzi full electric, mentre 12 stanno potenziando le linee tramviarie, con progetti di successo a Firenze e Padova. A Milano, il trasporto pubblico ha superato l’auto privata (48% contro 43%), segnando una svolta per la mobilità urbana. Bologna e Olbia, adottando il modello Città30, hanno ridotto significativamente incidenti ed emissioni inquinanti: a Bologna, nel primo anno, le emissioni da traffico sono diminuite del 29%, gli incidenti del 13% e quelli gravi del 31%.
A Roma, invece, si sta puntando sull’integrazione tra trasporto pubblico e sharing mobility: l’abbonamento annuale include corse gratuite su biciclette e monopattini in sharing, incentivando l’intermodalità. Messina, con il progetto MoveMe, ha ottenuto risultati simili.
Mobilità sostenibile e mobilità elettrica: il paradosso italiano
Nonostante l’Italia disponga di una rete di ricarica tra le migliori in Europa, con 64.391 punti installati (19 ogni 100 auto elettriche, contro i 14 della Francia e gli 8 della Germania), il numero di veicoli elettrici circolanti resta basso: in media, lo 0,55% del parco auto complessivo, con punte appena superiori all’1% a Milano e Roma. La diffusione è ostacolata da una percezione errata sulla scarsità di colonnine, spesso alimentata da fake news. Inoltre, la distribuzione delle stazioni di ricarica è ancora squilibrata: il 57% si trova al Nord, il 20% al Centro e solo il 23% nel Sud e nelle Isole.
Le richieste di Legambiente
Per accelerare la transizione ecologica e garantire la competitività dell’industria automobilistica italiana, Legambiente propone sei aree di intervento prioritarie:
- Investimenti strategici: ripristinare e potenziare il Fondo Automotive, vincolandolo a obiettivi di riconversione elettrica, e valutare una partecipazione pubblica in Stellantis, come fatto dalla Francia.
- Elettrificazione: puntare sull’elettrico per il trasporto terrestre, destinando biocarburanti ed e-fuel solo ai settori hard-to-abate (aviazione e navale).
- Infrastrutture di ricarica: potenziare la rete, specialmente sulle autostrade e nelle aree meno servite del Centro-Sud.
- Materie prime critiche: rilanciare le gigafactory e garantire almeno il 25% del fabbisogno nazionale tramite riciclo.
- Energia rinnovabile: accelerare l’indipendenza energetica attraverso il fotovoltaico e l’eolico, riducendo i costi dell’elettricità.
- Mobilità urbana sostenibile: investire sul trasporto pubblico locale, promuovere le Città30, incentivare la sharing mobility e favorire il leasing sociale per veicoli elettrici, come già avviene in Francia.